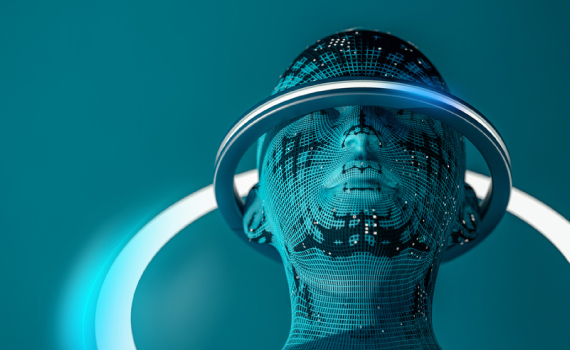L'intelligenza artificiale in Cina: strategia nazionale, proprietà industriale, regolamentazione e sfide globali
A cura di Gianluca Statti, Partner PRAXI Intellectual Property e Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Proprietà Intellettuale dell'Italy China Council Foundation
Negli ultimi dieci anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo economico e strategico della Repubblica Popolare Cinese. Spinta da una visione politica di lungo periodo, alimentata da un’enorme disponibilità di dati, da infrastrutture digitali capillari e da un sostegno istituzionale sistemico e coerente, la Cina si è progressivamente affermata come uno dei principali protagonisti mondiali nel settore dell’IA. Questo processo non è frutto di iniziative isolate o contingenti, bensì il risultato di una pianificazione meticolosa, multilivello e intersettoriale, che ha coinvolto congiuntamente il governo centrale, le amministrazioni locali, le grandi imprese tecnologiche, le università e i centri di ricerca pubblici e privati.
La strategia nazionale ha preso forma già a partire dal 2015 con l’ambizioso piano "Made in China 2025", nel quale la Cina ha individuato dieci settori tecnologici strategici in cui raggiungere l’autosufficienza industriale. Tra questi, l’intelligenza artificiale occupa una posizione di rilievo, come tecnologia abilitante e trasversale. Tale visione è stata rafforzata nel 2017 dal "New Generation Artificial Intelligence Development Plan", un documento programmatico che ha sancito l’intenzione esplicita del governo cinese di trasformare il Paese nella principale potenza mondiale dell’IA entro il 2030. Il piano, strutturato su tre tappe fondamentali per eguagliare i Paesi più avanzati entro il 2020, assumere la leadership dell’innovazione entro il 2025 e dominarne lo sviluppo globale entro la fine del decennio, ha prodotto effetti concreti a livello legislativo, industriale, accademico e finanziario.
In tale cornice, sono state attivate politiche di sostegno massivo alla ricerca scientifica, alla brevettazione, alla formazione di nuove competenze, alla creazione di poli tecnologici e alla sperimentazione in settori ad alto impatto sociale come la sanità, i trasporti, la pubblica sicurezza e l’istruzione. La pianificazione ha incluso incentivi fiscali, fondi pubblici, programmi di cooperazione internazionale e l’istituzione di zone pilota per la sperimentazione normativa, come le aree di libero scambio (Free Trade Zones) e i distretti ad alta intensità tecnologica.
I numeri testimoniano l’efficacia dell’approccio cinese. Tra il 2014 e il 2023, secondo i dati dell’OMPI e del CNIPA, la Cina ha depositato oltre 38.000 brevetti riguardanti l’IA generativa, un dato che supera di gran lunga quello degli Stati Uniti, che si ferma a circa 6.200 domande nello stesso periodo. Solo nel 2023, il 55% delle nuove domande depositate nel settore IA presso l’Ufficio Cinese per la Proprietà Intellettuale proveniva da imprese locali. La proprietà intellettuale, in Cina, non è solo uno strumento di protezione tecnologica: è anche un indicatore di progresso industriale, un mezzo di valutazione della competitività nazionale e un tassello chiave nella diplomazia economica del Paese.
Significativo è anche l’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi interni degli uffici brevettuali. Lo CNIPA utilizza da anni strumenti di classificazione automatica, motori semantici per la ricerca di anteriorità, sistemi predittivi per la valutazione della validità dei titoli e meccanismi digitalizzati di risoluzione delle controversie. Tali innovazioni, che hanno contribuito a ridurre i tempi di esame e ad hanno anche lo scopo di aumentare la qualità delle decisioni, sono oggi studiate anche da altri uffici brevettuali nel mondo come possibili modelli di riferimento.
A livello regionale, la governance cinese dell’IA si articola in programmi locali ambiziosi. La provincia del Zhejiang, ad esempio, ha adottato un piano dettagliato in 27 misure, con un investimento pubblico superiore ai mille miliardi di yuan. Questo programma include l’erogazione di sussidi per la registrazione internazionale dei marchi legati all’IA, la creazione di database per la prevenzione dei conflitti tra diritti di PI, e la promozione di standard normativi integrati per brevetti, software e segreti industriali. È significativo il fatto che il documento strategico del Zhejiang sottolinei la necessità di coniugare l’innovazione tecnologica con lo sviluppo normativo, individuando nella governance uno dei principali asset competitivi del territorio.
Allo stesso modo, la provincia del Jiangsu ha annunciato nel 2025 un articolato piano di valorizzazione della PI come leva per attrarre investimenti esteri e favorire il trasferimento tecnologico. Tra le misure più interessanti: l’ampliamento dei servizi pubblici brevettuali, l’introduzione di canali rapidi per la risoluzione amministrativa delle controversie, la creazione di hub regionali per la valorizzazione dei brevetti in settori strategici (biotech, energie rinnovabili, veicoli autonomi) e la promozione della partecipazione delle PMI alle filiere brevettuali nazionali.
L’apparato normativo si completa con pratiche sistemiche di sorveglianza e indagine. Il CNIPA ha lanciato nel 2025 una nuova indagine nazionale sulla proprietà brevettuale, coinvolgendo più di 13.000 imprese e analizzando oltre 40.000 titoli attivi. L’obiettivo è duplice: monitorare l’effettivo tasso di implementazione industriale dei brevetti e valutare il livello di enforcement a livello nazionale. L’approccio quantitativo, combinato con analisi qualitative sulle barriere all’applicazione dei diritti di PI, costituisce una risorsa strategica per la definizione delle politiche industriali.
Parallelamente, le principali aziende tecnologiche cinesi hanno fatto un salto di qualità nello sviluppo di sistemi IA generativi. Baidu ha lanciato il suo modello ERNIE Bot, già comparabile in termini prestazionali a GPT-4, utilizzato in scenari applicativi che spaziano dalla guida autonoma all’assistenza clinica, fino al customer care. Alibaba ha integrato l’IA generativa in tutti i suoi ecosistemi di e-commerce, logistica e cloud computing, mentre ByteDance utilizza modelli linguistici per ottimizzare la creazione automatica di contenuti video e audio. A fianco di questi colossi, un vivace ecosistema di start-up riceve supporto finanziario e infrastrutturale dalle autorità pubbliche per sviluppare soluzioni IA destinate all’agricoltura intelligente, alla gestione energetica, alla tutela ambientale e alla medicina personalizzata.
Il rapido avanzamento dell’IA solleva comunque interrogativi giuridici profondi, non solo sul tema della proprietà industriale, ma anche intellettuale, e dunque in materia di diritto d’autore, esattamente come accade in Europa ed in generale in tutto l’Occidente. La sentenza della Corte Internet di Pechino vale a dire un Tribunale interamente dedicato, in via esclusiva, alle controversie in qualsivoglia modo legate a internet ed attivo dal 2018 dopo quello di Hagzhou, istituito nel 2017, nel novembre 2023 ha riconosciuto, per la prima volta, la tutelabilità di un’immagine generata con sistemi IA, basandosi sull’apporto creativo dell’utente nella scelta dei prompt e dei parametri. Questo orientamento, che ha suscitato grande interesse a livello internazionale, rappresenta un punto di svolta nel dibattito sull’attribuzione della titolarità dei diritti nei contenuti generati da macchine.
Ancora più rilevante è la sentenza del Tribunale del Popolo di Changshu del 7 marzo 2025, che ha riconosciuto la titolarità del diritto d’autore in capo a un utente che aveva generato un’immagine con Midjourney e successivamente perfezionato l’opera con Photoshop. La Corte ha ritenuto che l’opera riflettesse le scelte e la disposizione uniche dell’utente, risultando dunque un’opera originale. Il tribunale ha condannato i convenuti, che avevano utilizzato l’opera senza autorizzazione, al risarcimento dei danni e alla pubblicazione di scuse. Il caso ha ribadito che la protezione si limita all’opera definitiva (nel caso, l’immagine 2D), ma ha anche chiarito che l’uso dell’idea centrale dell’opera non costituisce violazione, rafforzando il principio della distinzione tra idee e forma espressiva.
In questa direzione, la giurisprudenza cinese ha anticipato posizioni che altrove restano ancora incerte. Le decisioni della Corte Popolare del Distretto di Nanshan, della Corte Internet di Pechino e della Corte per la Proprietà Intellettuale di Pechino, già nel 2019 e nel 2020, avevano riconosciuto la protezione del copyright per testi assistiti dall’IA. Nel novembre 2023, la Corte Internet di Pechino ha riconosciuto il diritto d’autore su un’opera generata con Stable Diffusion, laddove l’utente aveva apportato scelte artistiche determinanti. Il principio guida che emerge da questa giurisprudenza è la centralità dell’input umano nella configurazione dell’opera, criterio condiviso anche dalle linee guida dell’Ufficio Copyright statunitense del 2023 e del 2025, che però negano protezione a output puramente generati da IA.
Nel frattempo, la Cina sta diventando leader mondiale sia nell’innovazione che nella regolamentazione dell’IA. A dicembre 2024, l’Amministrazione Nazionale per la Proprietà Intellettuale ha pubblicato linee guida sulle domande di brevetto per invenzioni legate all’IA, che si affianca ad un quadro di governance per la Sicurezza dell’IA, fondato su principi etici e orientamento al bene comune.
Il confronto con gli Stati Uniti, inevitabile sotto molti aspetti, mostra differenze strutturali e culturali profonde. Mentre la Cina adotta un approccio centralizzato, normativamente stringente e orientato alla sicurezza nazionale, gli Stati Uniti privilegiano un modello più flessibile, segmentato per settori e orientato alla libera iniziativa imprenditoriale. Tuttavia, entrambi i sistemi stanno convergendo su alcuni principi chiave: trasparenza algoritmica, audit etici, protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili, controllo umano nei processi decisionali automatizzati. La differenza fondamentale resta nel paradigma di governance: in Cina, l’algoritmo è materia di interesse pubblico e controllo politico, negli Stati Uniti è un asset di mercato sottoposto a regolazione settoriale.
Nel contesto geopolitico globale, l’IA è diventata un campo di competizione strategica. Le restrizioni statunitensi sull’export di chip avanzati e software di modellazione hanno indotto la Cina ad accelerare lo sviluppo di semiconduttori autoctoni, sostenere la ricerca nei materiali quantistici e stringere accordi tecnologici con Paesi terzi. In parallelo, Pechino ha rafforzato la propria presenza nei mercati emergenti proponendo soluzioni IA pronte all’uso, accompagnate da infrastrutture, formazione, supporto legale e compatibilità normativa locale. Questo approccio integrato, visibile nei progetti avviati in Africa, Sud-Est asiatico e America Latina, mira a consolidare l’influenza cinese come fornitore globale di tecnologia e regole.
La Cina, oggi, rappresenta un laboratorio avanzato nel quale le dimensioni tecnica, normativa, politica e industriale dell’IA si intrecciano in modo sistemico. La sua traiettoria non si limita a competere sui mercati: mira a scrivere le regole del gioco, a definire i confini dell’innovazione responsabile e a condizionare gli standard globali di sviluppo. Resta da vedere se questo modello riuscirà a conciliare efficienza e inclusività, controllo e creatività, rapidità e pluralismo. Una cosa, però, è già chiara: nella corsa mondiale all’intelligenza artificiale, la Cina ha segnato un passo decisivo, e le sue scelte odierne incideranno in modo strutturale sul futuro tecnologico globale per i decenni a venire.